UN “ESG” PARTY A DAVOS

Da domani 21 Gennaio anche quest’anno 2500 tra i leaders del mondo della politica, della finanza, del business, delle scienze e dello spettacolo, si riuniranno tra le nevi svizzere di Davos, nel cantone dei Grigioni, per dibattere di nobili temi economici e ambientali, ma anche, e soprattutto, per incontrarsi e fare affari, in nome della “sostenibilità”
UN CIRCOLO MOLTO ESCLUSIVO
Al World Economic Forum infatti si può accedere soltanto per invito, così come al Bildenberg e ad ogni circolo chiuso che si rispetti. Ragione per cui in tutto il territorio nei quattro giorni di convegno la sicurezza sarà ai massimi livelli: 5000 agenti segreti, cecchini e poliziotti ne garantiranno l’infrastruttura, oltre alle numerosissime guardie del corpo che seguiranno passo passo i delegati. Ogni struttura ricettiva di lusso ne sarà monopolizzata e i prezzi di qualsiasi cosa (trasporti, servizi, shopping eccetera…) saranno ovviamente alle stelle, mentre i rotocalchi ne chiacchiereranno per settimane a venire.
Perché i leaders del mondo vi si riuniscono, ci chiedevamo? Sicuramente per dibattere a porte chiuse dei temi più importanti che riguardano il destino dell’umanità, ma anche e soprattutto per trarne profitto: il forum dei potenti non a caso è economico, non ecumenico. Dall’analisi delle tendenze in atto e dalle opinioni che ne discenderanno, ne saranno influenzati: il prezzo dell’energia e delle materie prime, i cambi delle valute, i moltiplicatori di borsa per ciascun settore industriale e i tassi di interesse.

UN MURO DI SILENZIO DIVIDE IL FORUM DAL RESTO DEL MONDO
Difficile non notare l’infinita separatezza che ogni anno si accentua tra i giochi di quelle èlites globali e il destino del resto della popolazione umana che dipenderà non poco dalle decisioni che segretamente verranno prese in quella Turris Eburnea tra le montagne della Svizzera. Ma così gira il mondo: ogni èlite della storia ha fondato la sua potenza sullo sfruttamento delle risorse naturali e del lavoro umano, tanto materiale quanto intellettuale. E oggigiorno è sempre più difficile pensare a un futuro che riuscirà ad essere diverso.
Quest’anno più che mai il tema centrale del Forum sarà il futuro: quale futuro (vicino ma anche lontano) ci attende per l’ambiente, l’industria, l’istruzione, le città, le infrastrutture, l’economia e la finanza? La finalità ultima (ed esplicita) del Forum e dei suoi partecipanti è quella di modellarlo, perché sia migliore -sicuramente- ma anche per muoversi di conseguenza, e trarne beneficio.
L’AMBIENTE AL CENTRO DI OGNI DISCUSSIONE

I temi ambientali però, gli scienziati che li trattano e i leader d’opinione che li commentano saranno più che mai inquadrati per primi, sotto i riflettori del palcoscenico. E non soltanto per i rischi climatici e meteorologici che ne derivano, ma anche e soprattutto perché gli investimenti che oggi essi richiedono costituiscono un grosso affare tanto per chi li effettua quanto per chi li riceve, li adopera, o li finanzia. E tanto per donare un po’ di colore all’argomento, verrà lanciata l’iniziativa “un trilione di nuovi alberi nei prossimi dieci anni”!
E POCA ATTENZIONE ALLA CRESCITA ECONOMICA
Il tema della crescita economica sarà sicuramente importante anche per quest’anno ma non sarà più protagonista. Tanto per il fatto che al suo riguardo non si prevedono grandi sorprese (né molto altro che si può fare per sostenerla), quanto perché è alla sua sostenibilità che, per fortuna, la crisi ambientale ha fatto rivolgere la maggior attenzione degli operatori economici di tutto il mondo.

È IL MOMENTO DEGLI INVESTIMENTI ECO-SOSTENIBILI
È infatti agli investimenti ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) i quali, soprattutto per il fatto che saranno privilegiati dagli investitori di ogni parte del pianeta, saranno probabilmente anche quelli che si rivaluteranno di più.
Ovviamente dietro agli slogan bisogna che ci sia un po’ di sostanza, ma in questo caso non sarà facile distinguere la realtà dei fatti dalle mode e dalle illusioni. È un dato di fatto, per esempio, che gli investimenti infrastrutturali che la sostenibilità richiede saranno ingenti, e che la transizione energetica verso fonti “sostenibili” sarà lenta e costosa. E anche per questo motivo i profitti aziendali ne risentiranno, come probabilmente pure i tassi di interesse, che dovranno risultare ancora più bassi, perché la finanza globale resti in equilibrio e riesca a far fronte alla montadi liquidità che essi richiederanno.

CHI NE BENEFICIERÀ MAGGIORMENTE?
Ma la corsa dei risparmi e delle risorse pubbliche verso gli investimenti eco-sostenibili genererà a sua volta molte altre conseguenze, tanto per i settori industriali “tradizionali” che non potranno non esserne penalizzati, quanto per quelli collegati alla ricerca di una nuova naturalezza, a partire dall’agricoltura non più intensiva sino alle scienze farmaceutiche ed alimentari, che dovrebbero trarne il massimo giovamento.
La finanza globale ne sta tenendo conto, e sta facendo i suoi calcoli per adattarvisi. Ecco qui in basso ad esempio uno spaccato della quota di investimenti eco-sostenibili in percentuale sul totale, effettuati dai fondi investimento americani e in relazione alla totalità dei principali indici di borsa, portati come paragone.

E ancora una volta esiste un buon motivo per sostenere gli investimenti in tecnologia, considerata evidentemente panacea essenziale anche per favorire la transizione energetica, tanto attraverso i suoi strumenti informatici, quanto nella speranza che essa possa aiutare a costruire -con i suoi benefici- anche una “coscienza globale” che gli intellettuali di ogni angolo del mondo non erano riusciti a instillare alle nuove generazioni.
Stefano di Tommaso
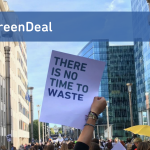
 Se da un lato vengono alla mente due ovvie considerazioni (che evidentemente la tecnologia in questo senso non ha fatto passi avanti davvero significativi e che ci sono sempre forti interessi in gioco quando si parla di energia), dall’altro lato ognuno di noi in fondo deve anche considerare l’aspetto positivo di questa manovra, volta a generare una maggior attenzione da parte dei governi locali e dell’opinione pubblica al tema dell’inquinamento atmosferico, e che non può che generare iniziative di ogni genere volte a ribaltare i precedenti canoni dell’industria manifatturiera per trovare soluzioni migliori dal punto di vista ambientale alle esigenze produttive e abitative d’Europa e dell’intera umanità.
Se da un lato vengono alla mente due ovvie considerazioni (che evidentemente la tecnologia in questo senso non ha fatto passi avanti davvero significativi e che ci sono sempre forti interessi in gioco quando si parla di energia), dall’altro lato ognuno di noi in fondo deve anche considerare l’aspetto positivo di questa manovra, volta a generare una maggior attenzione da parte dei governi locali e dell’opinione pubblica al tema dell’inquinamento atmosferico, e che non può che generare iniziative di ogni genere volte a ribaltare i precedenti canoni dell’industria manifatturiera per trovare soluzioni migliori dal punto di vista ambientale alle esigenze produttive e abitative d’Europa e dell’intera umanità. Da questa prospettiva non stupisce dunque che il Paese più attivo sul fronte delle iniziative che ne conseguono sia proprio la Germania, dove l’industria ha prosperato per decenni grazie alla disponibilità di carbone nel bacino della Ruhr e dove si produce ancor oggi il quarto maggior numero di veicoli inquinanti al mondo.
Da questa prospettiva non stupisce dunque che il Paese più attivo sul fronte delle iniziative che ne conseguono sia proprio la Germania, dove l’industria ha prosperato per decenni grazie alla disponibilità di carbone nel bacino della Ruhr e dove si produce ancor oggi il quarto maggior numero di veicoli inquinanti al mondo.


























 Se poi da tale sconvolgimento dovesse risultare una vittoria democratica alle elezioni presidenziali del prossimo novembre si aggiungerebbe anche un incremento della tassazione per le imprese americane, le quali tuttavia contano per più della metà dell’indice azionario globale!Le previsioni attese per la media degli utili aziendali da parte di Goldman Sachs in questo scenario sarebbero le seguenti :
Se poi da tale sconvolgimento dovesse risultare una vittoria democratica alle elezioni presidenziali del prossimo novembre si aggiungerebbe anche un incremento della tassazione per le imprese americane, le quali tuttavia contano per più della metà dell’indice azionario globale!Le previsioni attese per la media degli utili aziendali da parte di Goldman Sachs in questo scenario sarebbero le seguenti :
