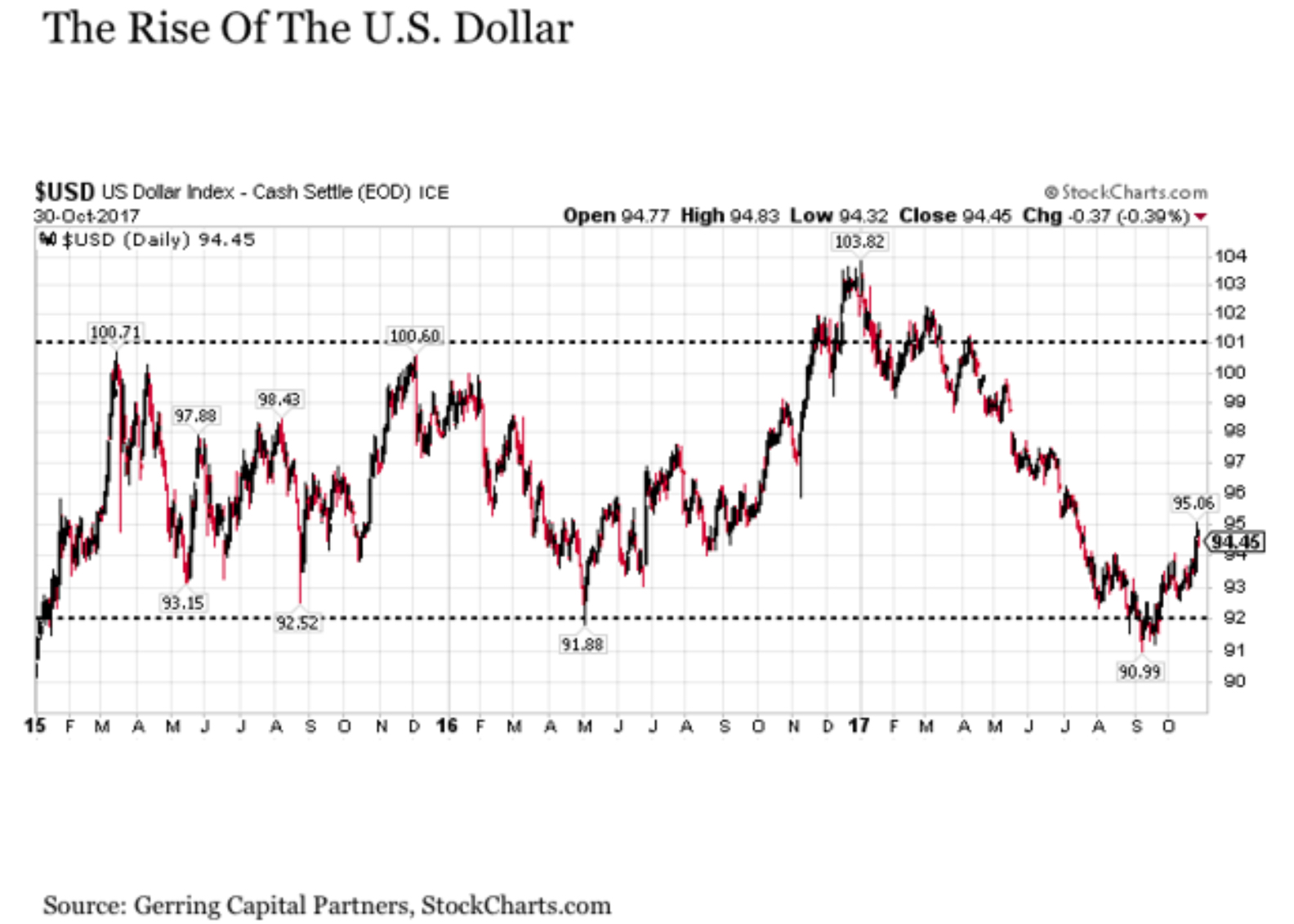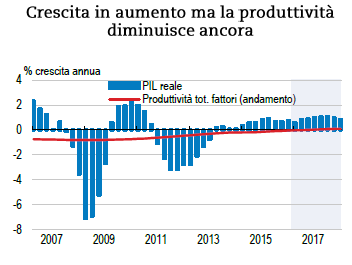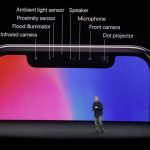HA ANCORA SENSO LA RICERCA DEL VALORE NELL’INVESTIMENTO AZIONARIO? FORSE SOLO NEL SETTORE DELLA ROBOTICA

Esistono ancora dei paradigmi per la selezione delle azioni sulle quali investire in una logica di lungo periodo? Se lo chiede nella sua lettera agli investitori uno dei più famosi gestori di hedge funds d’America, David Einhorn, principal della Greenlight Capital, società di investimenti con circa dieci miliardi di dollari in gestione.
 Famosissimo campione di poker e arcinoto tra l’altro per aver venduto allo scoperto azioni Lehman Brothers nel 2007, Einhorn è stato sino ad oggi anche un fiero paladino della strategia del cosiddetto “value investing”. Famosa è stata altresì la sua battaglia del 2015 contro l’hydraulic fracturing (o “fracking”) nell’estrazione del petrolio, asserendo che un business che non ha vere barriere all’entrata della concorrenza e al tempo stesso non cresce e non genera cassa, in realtà non vale niente. I tempi gli hanno più volte dato ragione nella sua ricerca di una razionalità che alla fine riesca a prevalere.
Famosissimo campione di poker e arcinoto tra l’altro per aver venduto allo scoperto azioni Lehman Brothers nel 2007, Einhorn è stato sino ad oggi anche un fiero paladino della strategia del cosiddetto “value investing”. Famosa è stata altresì la sua battaglia del 2015 contro l’hydraulic fracturing (o “fracking”) nell’estrazione del petrolio, asserendo che un business che non ha vere barriere all’entrata della concorrenza e al tempo stesso non cresce e non genera cassa, in realtà non vale niente. I tempi gli hanno più volte dato ragione nella sua ricerca di una razionalità che alla fine riesca a prevalere.

VALUE STOCKS CONTRO GROWTH STOCKS
La questione della ricerca del valore nelle azioni quotate è quantomai attuale, sia perché tra i più noti paladini di questa scuola è uno degli investitori più ricchi al mondo (il miliardario Warren Buffet) e poi per il fatto che da diversi mesi oramai la borsa americana ha soprattutto premiato le azioni con il maggior potenziale di sviluppo (le cosiddette “growth stocks”) che in termini concettuali rappresentano spesso la negazione della strategia di investimento nelle “value stocks”. Le azioni “value” troppo spesso esercitano un fascino irresistibile: bassi moltiplicatori del reddito, elevata generazione di cassa, decisa conservativitá nella loro conduzione manageriale sono solo alcuni tra i fattori che le pongono in primo piano tra gli investitori tradizionali.
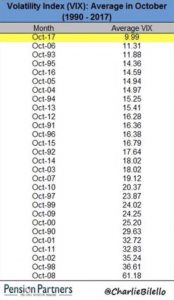 Tra le growth stocks troviamo invece tipicamente titoli estremamente nuovi e fortemente sopravvalutati, quali Amazon, Netflix, Facebook e Paypal. Per converso tra le value stocks troviamo invece titoli emessi da aziende decisamente più legate all’economia reale, come McDonald, AT&T, Stanley Black&Decker, IBM. Le prime sono spesso valutate dalla borsa per centinaia di volte gli utili attesi, ma sicuramente mostrano -per tecnologia o per la particolare innovatività della formula imprenditoriale, le maggiori potenzialità di sviluppo nel futuro. Le seconde rappresentano una logica più difensiva, basata più sui valori fondamentali che non sulla scia del consenso di mercato, ma ovviamente in una situazione di crescita quasi indiscriminata dei listini le quotazioni delle “value stocks” corrono molto meno delle altre.
Tra le growth stocks troviamo invece tipicamente titoli estremamente nuovi e fortemente sopravvalutati, quali Amazon, Netflix, Facebook e Paypal. Per converso tra le value stocks troviamo invece titoli emessi da aziende decisamente più legate all’economia reale, come McDonald, AT&T, Stanley Black&Decker, IBM. Le prime sono spesso valutate dalla borsa per centinaia di volte gli utili attesi, ma sicuramente mostrano -per tecnologia o per la particolare innovatività della formula imprenditoriale, le maggiori potenzialità di sviluppo nel futuro. Le seconde rappresentano una logica più difensiva, basata più sui valori fondamentali che non sulla scia del consenso di mercato, ma ovviamente in una situazione di crescita quasi indiscriminata dei listini le quotazioni delle “value stocks” corrono molto meno delle altre.
È GIUNTO IL MOMENTO DI RIVALUTARE L’ECONOMIA REALE?
Oggi che tutti si chiedono più che in passato se con Wall Street che continua a sfondare ogni precedente record siamo forse arrivati al punto di massima di un “trend” di mercato che oramai va avanti da più di otto anni, il tema della ricerca del valore intrinseco delle aziende quotate torna di grande attualità!
Sia però ben chiaro: David Einhorn è invece palesemente sfiduciato. Se la crescita dei listini si associa ad una volatilità bassissima e ad una strada a senso unico, se l’investimento nei titoli a reddito fisso mostra più che mai tutte le sue criticità per gli schiaffi che può ricevere dal quasi scontato programma di rialzo dei tassi di interesse, forse siamo arrivati in un’era che prevede nuovi paradigmi per gli investimenti, conclude il capo di Greenlight Capital nella sua allocuzione agli investitori.

LA ROBOTICA E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Se tuttavia sino ad oggi la ricerca del valore nelle imprese quotate è stata equivalente al fare consistenti sacrifici rispetto alla performances degli indici di borsa, bisogna anche notare che esistono però delle meravigliose eccezioni come i titoli legati alla robotica, che hanno invece avuto una performance complessiva assolutamente in linea con i migliori titoli quotati. L’indice ETFS Robo-Stoxx Global Robotis and Automation che li rappresenta è attualmente composto da un migliaio di aziende che presentano un P/E medio di 27,5 volte (abbastanza elevato rispetto all’intero mercato per via delle notevoli performance espresse negli ultimi anni ma comunque lontano anni luce dalle centinaia di volte di Amazon o Netflix).
 È pur sempre un investimento da valutare in chiave strategica, con orizzonti preferibilmente di almeno cinque anni, ma una recente ricerca di Boston Consulting Group ha evidenziato che la crescita annua stimata per il prossimo decennio del mercato globale della robotica si attesta almeno attorno al 10% annuo. Dunque un comparto di titoli cari ma al tempo stesso che rappresentano insieme tematiche di valore reale e potenzialità di crescita.
È pur sempre un investimento da valutare in chiave strategica, con orizzonti preferibilmente di almeno cinque anni, ma una recente ricerca di Boston Consulting Group ha evidenziato che la crescita annua stimata per il prossimo decennio del mercato globale della robotica si attesta almeno attorno al 10% annuo. Dunque un comparto di titoli cari ma al tempo stesso che rappresentano insieme tematiche di valore reale e potenzialità di crescita.
All’interno dell’indice l’automazione industriale pesa per quasi il 30%, seguita dal 17% di computer e microprocessori,e poi al pari (9% ciascuno) dai sensori, dalle macchine per l’automazione della logistica e dalle apparecchiature per l’health care. La stampa 3D incide invece ancora molto poco: il 4% del paniere. In termini di Paesi il 43% è rappresentato da società americane, il 27% giapponesi e il 6% tedesche. Le società a media capitalizzazione contano per metà dell’indice, seguite dal 26% delle PMI e dal 24% di aziende ad elevata capitalizzazione.
I RITORNI ATTESI DAGLI INVESTIMENTI AZIONARI PER I PROSSIMI SETTE ANNI APPAIONO IN MOLTI CASI NEGATIVI
Al di fuori di tale comparto però il panorama, per un investitore che arrivasse da un altro pianeta soltanto a Novembre 2017 apparirebbe abbastanza sconfortante. Se da un lato è vero che le innovazioni che si susseguono nella tecnologia, nell’intelligenza artificiale, nella cura delle malattie e nella costruzione di veicoli di ogni genere comportano una prospettiva di grande efficienza nei costi (che si riflette nella bassa inflazione dei prezzi al consumo) e di continuo stimolo della domanda che fa incrementare il giro d’affari e la profittabilitá delle imprese (e dunque la loro capitalizzazione), dall’altro lato i titoli che più hanno beneficiato di questi trend appaiono oggi tutti lontani dall’economia reale, tutti ipervalutati (Apple, Alphabet, Tesla, Facebook eccetera) e per lo più fortemente collegati a programmi di riacquisto delle azioni proprie che li mantengono artificialmente ai massimi di sempre.

Lo stesso vale per i titoli obbligazionari. Se prendiamo alla lettera i programmi di riduzione della liquidità immessa in passato artificialmente sui mercati dalle banche centrali e prendiamo altresì le loro intenzioni di innalzamento dei tassi di interesse, difficilmente si otterrà un reddito positivo dall’investire oggi in titoli di stato e obbligazioni.
Il punto non è dunque cosa fare se i mercati crollano rovinosamente a causa dell’attuale eccesso di “compiacenza” degli investitori con una situazione apparentemente idilliaca. Anche perché una minor perdita in conto capitale ottenuta dall’aver rotato per tempo i portafogli verso titoli più “difensivi” rappresenterebbe soltanto una classica vittoria di Pirro.
LA DIFFICILE RICERCA DEL VALORE PUÒ NON PORTARE DA NESSUNA PARTE
Il vero punto per gli investitori del risparmio e di fondi pensione è casomai il dove andare a reperire, anche in costanza dei mercati, delle reali prospettive di estrazione futura di valore dagli investimenti possibili.
Cosa difficile in assoluto, se non nelle piccolissime imprese che un domani potranno diventare grandi. Ovviamente però questo genere di investimenti si accompagna ad un bassissimo grado di liquidabilitá e alla possibilità che esse non brillino per trasparenza nei conti e che dunque nascondano delle vere e proprie “fregature”.
Tanto meglio allora potrebbe risultare l’investire negli immobili, oppure nei fondi di private equity e venture capital, i quali anch’essi tuttavia potrebbero risultare in uno stato di eccessiva valutazione al momento dell’eventuale scoppio della bolla speculativa in corso.
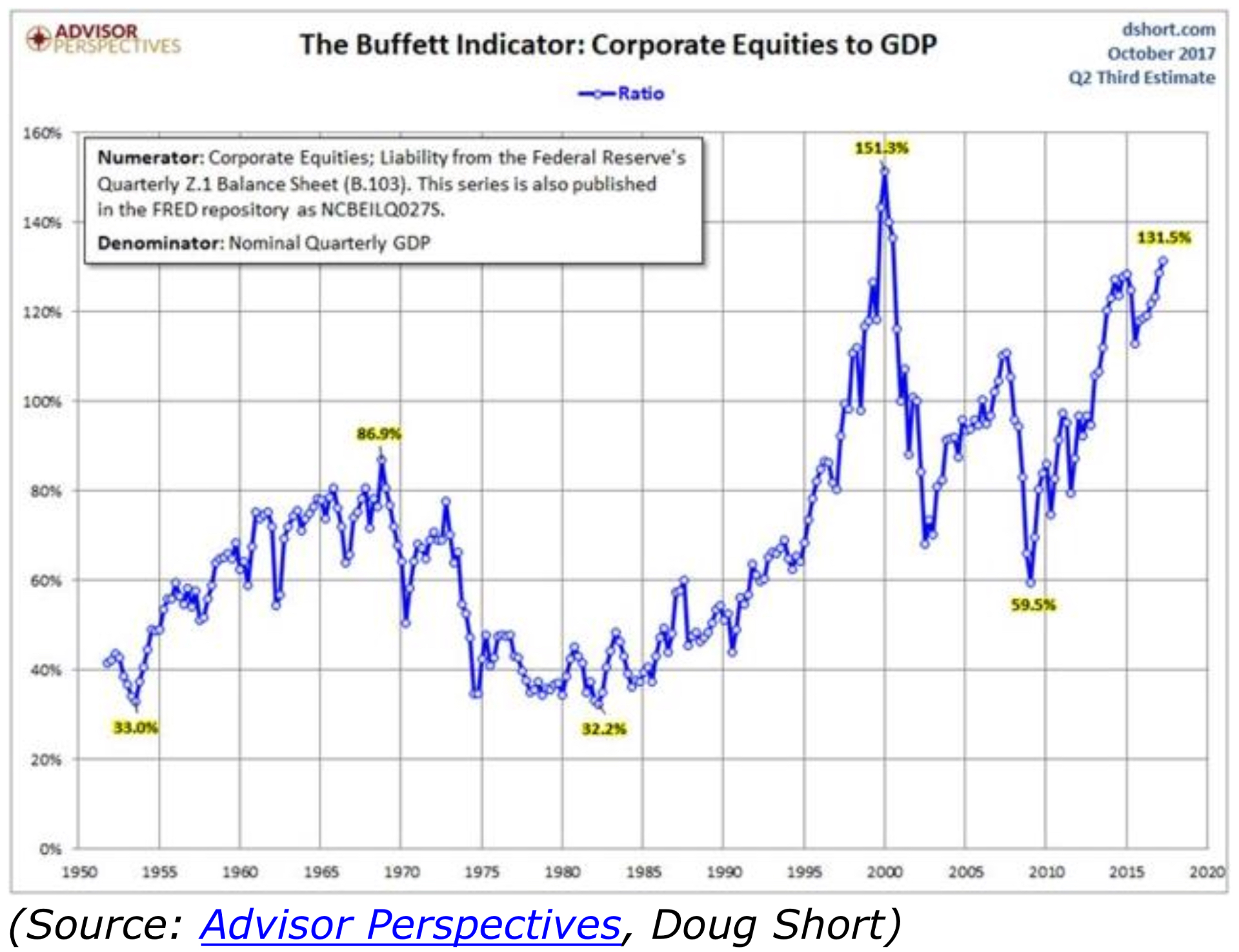
MORALE: FOLLOW THE MONEY
La morale sull’eterna questione relativa a dove andare a sbattere il naso l’hanno tuttavia probabilmente già segnata da tempo i mercati borsistici, che a volte seguono logiche completamente indipendenti da quelle degli investitori professionali: oggi seguire i trend (e annusarne la possibile inversione) rischia di contare molto più dell’allocare delle scommesse sulle scelte razionali basate sull’analisi fondamentale.
Ci sono troppe variabili derivanti dai macrotrend in atto: dalla poderosa crescita economica globale al fatto che non è per nulla scontato che la liquidità in circolazione tenderà a ridursi. La crescita dei profitti aziendali potrebbe poi continuare così come il rapido spostamento dei consumi e degli investimenti verso le nuove tecnologie e le modalità di business più estreme. Sono tutte ragioni per le quali sino ad oggi il “growth investing” ha costantemente avuto la meglio sulla ricerca spasmodica del valore. Nessuno ci garantisce che la tendenza non durerà a lungo.
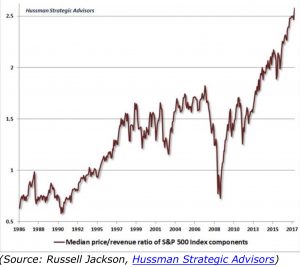 Tornerà sicuramente ancora una volta il momento del “value investing”, poiché anche un orologio fermo due volte al giorno segna l’ora esatta, ma probabilmente tale momento non è esattamente quello attuale. Non almeno sin tanto che non cambierà piuttosto radicalmente lo scenario globale degli altri investitori, apparentemente molto più fortemente orientati al “mordi e fuggi”. Difficile perciò investire controcorrente. Meglio forse restare in campana e, dunque, guardarsi intorno con circospezione. Il ciclo borsistico attuale appare quanto mai maturo.
Tornerà sicuramente ancora una volta il momento del “value investing”, poiché anche un orologio fermo due volte al giorno segna l’ora esatta, ma probabilmente tale momento non è esattamente quello attuale. Non almeno sin tanto che non cambierà piuttosto radicalmente lo scenario globale degli altri investitori, apparentemente molto più fortemente orientati al “mordi e fuggi”. Difficile perciò investire controcorrente. Meglio forse restare in campana e, dunque, guardarsi intorno con circospezione. Il ciclo borsistico attuale appare quanto mai maturo.
Stefano di Tommaso