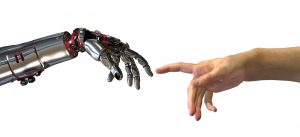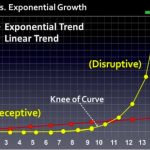LA STAGIONE ITALIANA DELL’M&A

Molte altre volte in passato si era pensato che la peculiarità della piccola dimensione delle imprese italiane, talune delle quali estremamente competitive e miracolosamente capaci di compiere realizzazioni straordinarie, le avrebbe spinte prima o poi verso un processo di rapida aggregazione delle une con le altre, quantomeno allo scopo di liberare risorse e attirare capitali.
E poi nulla o quasi.
Molti fattori hanno frenato o impedito quella corsa. Dalla scarsità di credito alla sotto-capitalizzazione fino alla natura estremamente circoscritta alla famiglia del fondatore di buona parte delle imprese italiane di successo.
NON PIÙ “PICCOLO È BELLO”

È tempo ormai che è finita l’epoca del “piccolo è bello” . Uno slogan che faceva riferimento alla capacità di adattamento e di innovazione delle PMI, che avrebbero fatto premio sulle efficienze derivanti dalla grande dimensione.
Oggi, alla luce dei cospicui investimenti necessari per balzare sul carro delle nuove tecnologie e a causa della globalizzazione della concorrenza sui mercati di sbocco (a sua volta in buona parte dovuta alle vendite online che continuano a crescere sbaragliando i canali distributivi convenzionali), il paradigma dell’azienda di successo sta tornando rapidamente verso fatturati più rotondi e, soprattutto, verso la capacità di attirare finanziamenti e capitali per la crescita (che, notoriamente, mal si sposano con la piccola dimensione).
E qual’è la strada più veloce e più sicura per crescere dimensionalmente nel business dal momento che essa sembra la prima delle chiavi del successo d’impresa? Ovviamente quella di acquisirne un’altra o -ancor meglio- quella di fondersi con un’altra, attivando ugualmente le sinergie possibili e migliorando le dimensioni senza nemmeno dover tirare fuori quattrini per farlo! Semplice, vero?
POCHE ACQUISIZIONI E QUASI NESSUNA FUSIONE TRA LE IMPRESE ITALIANE

E invece no: questo semplice ragionamento non sembra tenere alla prova dei fatti, quantomeno in Italia. Poiché almeno dieci volte negli ultimi anni si è auspicata una vera e propria esplosione delle fusioni e acquisizioni che per qualche motivo non c’è poi invece mai stata, dobbiamo dedurne che ci sono molte altre determinanti in gioco nel nostro Paese che impediscono di perseguire la crescita aziendale.
Inutile ripeterci che da noi le imprese sono quasi tutte famigliari e sottocapitalizzate, spesso immerse in distretti super specializzati per know-how e che la risposta alla questione fatidica “chi comanda?” evidentemente conta ben più del reddito e della dinamica della creazione di valore.
QUALCOSA STA CAMBIANDO
Qualcosa però si sta muovendo: sono state censite 551 acquisizioni nei primi 9 mesi del 2016 per un controvalore di € 33 miliardi, in aumento del 56% rispetto ai 25 miliardi del 2015. Di quelle 551 sono poi 110 le acquisizioni oltreconfine per €11,8 miliardi e questa sì che è una notizia! Erano forse vent’anni che le imprese italiane non sceglievano così pesantemente la strada delle acquisizioni all’estero.
Per quel che si può vedere dal nostro osservatorio peraltro la corsa prosegue, anche perché nel 2017 finalmente le risorse finanziarie per scalare la montagna del successo questa volta sono disponibili in quantità più cospicue, dal credito bancario ai fondi che sottoscrivono i Minibond fino alle emissioni azionarie da collocare all’A.I.M. della Borsa Italiana.
Anche la trasparenza nei bilanci e nelle modalità di gestione aziendale (più managers e meno “rampolli”), almeno al Nord-Italia, è migliorata negli ultimi anni, così come il numero delle società che hanno scelto di far revisionare ufficialmente i propri bilanci.
Ciò fluidifica il processo e provoca più attenzione da parte degli investitori, mentre il ritmo delle operazioni aumenta soprattutto a causa dell’enorme arretrato in cui giaceva il tessuto economico del Paese.
RECUPERARE IL TERRENO PERDUTO

Con la più elevata frammentazione industriale tra i Paesi avanzati, il più arretrato dei sistemi distributivi e la più problematica tra le reti infrastrutturali per trasporti e logistica, all’azienda-Italia non resta che valutare molto seriamente la possibilità di recuperare il terreno perduto attraverso una corsa alle aggregazioni e concentrazioni di settore!
Anche perché può valere pure il ragionamento opposto: se per crescere ho bisogno di risorse finanziarie e con la mia piccola dimensione nessuno me le fornisce, allora per la mia azienda è meglio superare determinate soglie dimensionali e rendere i suoi conti più trasparenti per evitare di morire di inedia finanziaria!
Per lo stesso motivo crescono vorticosamente le imprese che stanno iniziando a considerare l’entrata in borsa (per la massima parte al segmento A.I.M., cioè il circuito riservato alle piccole e medie imprese), sebbene tra il considerarlo e il farlo permangano numerosi impedimenti di ogni genere che per ora hanno partorito ben poche conclusioni positive rispetto alle migliaia di imprese che potrebbero farlo e alle centinaia di aziende iscritte al circuito “Elite” della Borsa italiana, con il quale quest’ultima ha inteso iniziare a preparare gli imprenditori al grande passo.
LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

Ma al di là delle risorse finanziarie la vera scommessa per le aziende nostrane è la collaborazione e/o aggregazione a livello internazionale con coloro che possono fornire loro le esperienze già maturate in mercati più consolidati ovvero le tecnologie mancanti: è quello l’agòne dove si gioca il futuro dell’imprenditoria italiana! Ed è anche la strada più complessa, quella più insidiosa ma anche la più interessante per coloro che non si limitano ad essere reattivi agli stimoli del mercato, ma desiderano coglierne i mutamenti e cavalcarne le onde in modo “pro-attivo”.
Terrorismo, crisi finanziarie e shock energetici permettendo, la crescita economica del Bel Paese sembra finalmente aver imboccato l’autostrada delle operazioni straordinarie, della raccolta di capitale di rischio e dell’interazione internazionale!
Fosse questa la volta buona ?
Stefano di Tommaso

 Il Prof. Luca Pieroni
Il Prof. Luca Pieroni